Il diritto canonico
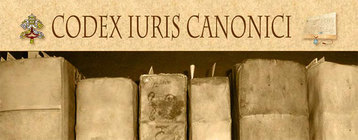
Il diritto canonico è costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna.
Si applica altresì come diritto statuale proprio all'interno dello Stato della Città del Vaticano. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati regolano i loro rapporti coi credenti e con le varie confessioni religiose.
Storia
Periodo pregrazianeo: primo Millennio
Questo periodo comprende il primo Millennio di vita della Chiesa cattolica, dalle origini delle prime comunità fino all'avvento della figura centrale di Graziano. Nella prima parte di questo periodo, quindi dalle origini della Chiesa fino all'Editto di Costantino (313) il diritto canonico era basato esclusivamente su quello divino, quindi sulle Sacre Scritture e sul diritto naturale.
Poco diritto veniva disciplinato e molto veniva ereditato dal diritto ebraico. Proprio perché siamo alla presenza di una legge rivelata da Dio, bisogna parlare di una legge di "Alleanza". Il decalogo, ossia i Dieci comandamenti rivelati a Mosè sul monte Sinai, sono la base fondamentale. Insieme al decalogo, erano stati elaborati altri precetti. Il problema, a livello giuridico, è che precetti e legge erano messi tutti sullo stesso piano, non garantendo una gerarchia. Successivamente, oltre agli Atti degli apostoli che mostrano un primo assetto della comunità cristiana, si inseriscono altri scritti dal II secolo fino al VII secolo, come Barnaba, Clemente romano, Ignazio, Policarpo, Erma sino ai Padri della Chiesa (Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Girolamo eccetera). È con l'evoluzione di questi secoli che tra le fonti del diritto sorge la Tradizione, ovvero gli insegnamenti degli apostoli e dei loro successori, ma anche un approfondimento filosofico e non della fede e dei vari principi morali. (continua a leggere)
Periodo classico: XII-XVI secolo
Il cosiddetto periodo classico del diritto canonico inizia nel XII secolo, più precisamente dal 1140 circa, periodo in cui Graziano compie la prima effettiva opera giuridica su testi canonici, il famoso Decretum: il monaco camaldolese colleziona un'enorme raccolta di fonti canoniche ed elabora numerose interpretazioni su quelle contrastanti, fino a quel momento, infatti, il diritto canonico è solo un insieme di leggi, alcune norme potevano apparire in contrasto con altre. Tale opera entrerà a far parte del Corpus Iuris Canonici.
Successivamente, in coincidenza col fiorire delle università italiane e della dottrina giuridica, il Decretum riceve molti commenti, glosse ed è oggetto di numerosi studi, mentre al contempo prende piede un'altra fonte di diritto canonico di origine pontificia, ovvero l'iniziativa in base a causae maior (questioni importanti di natura immediata). Il fatto storico che chiude questo periodo, e stravolge nettamente l'assetto della Chiesa, è la Riforma Protestante, col conseguente e necessario Concilio di Trento che fissa regole dottrinarie ma anche e soprattutto disciplinari, contribuendo all'aspetto giuridico dell'organizzazione ecclesiastica in maniera rilevantissima. (continua a leggere)
Periodo contemporaneo: dal XX secolo
Dopo un periodo di isolamento della Chiesa nelle relazioni internazionali, dovuto all'estromissione del diritto canonico dagli ordinamenti statali, Pio X costituì una pontificia commissione a cui partecipò anche Franz Xaver Wernz (1904-1917) e Benedetto XV promulgò il nuovo codice del 1917 col nome di "Piano Benedettino". Pietro Gasparri fece la sintesi di tutta la sapientia giuridica mettendola in un codice. Benedetto XV dà vita alla Pontificia commissione per l’interpretazione autentica del codice di diritto canonico. Risponde ai quesiti sul codice, sotto parere del pontefice, e, dopo il responso, permette che l’interpretazione divenga autentica, cioè proveniente dalla stesso autore della legge, e vincolante: entra a integrare la legge.
Fu il papa Giovanni XXIII a dare segnali di voler cambiare e ammodernare il nuovo codice, non adatto già ai tempi. Il nuovo codice fu promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 (con la Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae legis), con varie caratteristiche: armonizzazione del diritto sancito nel codice precedente ai vari concili, specialmente al Concilio Vaticano II, allontanamento dai codici secolari (contrario al codice del 1917 che vi si avvicinava notevolmente). Nell'ottobre 2008 Papa Benedetto XVI ha approvato la nuova legge sulle fonti del diritto per lo stato del Vaticano. La legge, entrata in vigore il 1º gennaio 2009, sostituisce quella del 7 giugno 1929, che fu emanata in seguito alla stipula dei patti lateranensi l'11 febbraio dello stesso anno.
La nuova legge riconosce che l'ordinamento canonico diventerà la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane e di altri Stati non verranno più recepite automaticamente, ma entreranno nell'ordinamento solo dopo una previa ed esplicita autorizzazione pontificia. Nel luglio 2013 con "motu proprio", quale sovrano assoluto, papa Francesco ha provveduto a modifiche della parte penale del diritto canonico, che si applica quasi esclusivamente all'interno dello Stato della Città del Vaticano.
Caratteristiche
Nonostante ovviamente sia radicato su una religione ben definita, il diritto canonico si discosta molto dalla shari'a islamica o dal diritto ebraico per essere molto vicino al diritto secolare degli stati,[senza fonte] ma allo stesso tempo non assume un'identità statale in quanto è destinato ad una massa di fedeli stanziata in tutto il mondo e non distribuita all'interno d'un territorio ben definito: parallelamente è distante dal concetto di stato anche perché il diritto canonico proviene ed è diretto ad un altro mondo e non quello terreno. Elemento caratterizzante della legge canonico è quindi la persona.[senza fonte] Si applica a pieno sia come diritto civile che penale all'interno dello Stato della Città del Vaticano.
In sostanza è costituito da quell’insieme di norme, provenienti direttamente dal papa (come sovrano assoluto), che:
Terminologia
La parola canonico deriva dal corrispettivo greco κανών, che significa semplicemente "regola", ed è stato usata in maniera inequivocabile nel Concilio di Nicea (325 d.C.) quando furono trattati i canones disciplinares, ma il suo uso ha cominciato a ricevere preferenze nette solo dall'VIII secolo. Tuttavia nel corso della storia della Chiesa si è parlato spesso anche di ius sacrum, ius decretalium, ius pontificium e ius ecclesiasticum. Dal Concilio Vaticano II il termine diritto canonico è stato spesso sostituito da quello di "diritto ecclesiale", che meglio risponde alle ragioni fondative della Chiesa.
Un'altra distinzione nasce dal fatto che la Chiesa si definisce un’unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, regolata correlativamente sia dal diritto divino sia dal diritto (meramente) ecclesiastico, ovvero dalle norme stabilite esclusivamente dalla competente autorità ecclesiastica. Si osservi che in questo caso con diritto ecclesiastico la Chiesa intende qualcosa di totalmente diverso da quanto indicato con lo stesso nome dagli stati, come spiegato in precedenza. Il diritto divino si divide in naturale e positivo: del primo fanno parte tutti i diritti umani intrinsechi alla natura umana stessa; del secondo tutte le regole manifestate nella Rivelazione divina, ricavabili dai testi sacri e dalla Tradizione apostolica.
Tratto da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vedi il "CODICE DI DIRITTO CANONICO" per intero su: http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM
Vedi anche:
99 Differenze tra l'Ortodossia e il Cattolicesimo Romano
Protestanti e cattolici: le differenze
Si applica altresì come diritto statuale proprio all'interno dello Stato della Città del Vaticano. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati regolano i loro rapporti coi credenti e con le varie confessioni religiose.
Storia
Periodo pregrazianeo: primo Millennio
Questo periodo comprende il primo Millennio di vita della Chiesa cattolica, dalle origini delle prime comunità fino all'avvento della figura centrale di Graziano. Nella prima parte di questo periodo, quindi dalle origini della Chiesa fino all'Editto di Costantino (313) il diritto canonico era basato esclusivamente su quello divino, quindi sulle Sacre Scritture e sul diritto naturale.
Poco diritto veniva disciplinato e molto veniva ereditato dal diritto ebraico. Proprio perché siamo alla presenza di una legge rivelata da Dio, bisogna parlare di una legge di "Alleanza". Il decalogo, ossia i Dieci comandamenti rivelati a Mosè sul monte Sinai, sono la base fondamentale. Insieme al decalogo, erano stati elaborati altri precetti. Il problema, a livello giuridico, è che precetti e legge erano messi tutti sullo stesso piano, non garantendo una gerarchia. Successivamente, oltre agli Atti degli apostoli che mostrano un primo assetto della comunità cristiana, si inseriscono altri scritti dal II secolo fino al VII secolo, come Barnaba, Clemente romano, Ignazio, Policarpo, Erma sino ai Padri della Chiesa (Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Girolamo eccetera). È con l'evoluzione di questi secoli che tra le fonti del diritto sorge la Tradizione, ovvero gli insegnamenti degli apostoli e dei loro successori, ma anche un approfondimento filosofico e non della fede e dei vari principi morali. (continua a leggere)
Periodo classico: XII-XVI secolo
Il cosiddetto periodo classico del diritto canonico inizia nel XII secolo, più precisamente dal 1140 circa, periodo in cui Graziano compie la prima effettiva opera giuridica su testi canonici, il famoso Decretum: il monaco camaldolese colleziona un'enorme raccolta di fonti canoniche ed elabora numerose interpretazioni su quelle contrastanti, fino a quel momento, infatti, il diritto canonico è solo un insieme di leggi, alcune norme potevano apparire in contrasto con altre. Tale opera entrerà a far parte del Corpus Iuris Canonici.
Successivamente, in coincidenza col fiorire delle università italiane e della dottrina giuridica, il Decretum riceve molti commenti, glosse ed è oggetto di numerosi studi, mentre al contempo prende piede un'altra fonte di diritto canonico di origine pontificia, ovvero l'iniziativa in base a causae maior (questioni importanti di natura immediata). Il fatto storico che chiude questo periodo, e stravolge nettamente l'assetto della Chiesa, è la Riforma Protestante, col conseguente e necessario Concilio di Trento che fissa regole dottrinarie ma anche e soprattutto disciplinari, contribuendo all'aspetto giuridico dell'organizzazione ecclesiastica in maniera rilevantissima. (continua a leggere)
Periodo contemporaneo: dal XX secolo
Dopo un periodo di isolamento della Chiesa nelle relazioni internazionali, dovuto all'estromissione del diritto canonico dagli ordinamenti statali, Pio X costituì una pontificia commissione a cui partecipò anche Franz Xaver Wernz (1904-1917) e Benedetto XV promulgò il nuovo codice del 1917 col nome di "Piano Benedettino". Pietro Gasparri fece la sintesi di tutta la sapientia giuridica mettendola in un codice. Benedetto XV dà vita alla Pontificia commissione per l’interpretazione autentica del codice di diritto canonico. Risponde ai quesiti sul codice, sotto parere del pontefice, e, dopo il responso, permette che l’interpretazione divenga autentica, cioè proveniente dalla stesso autore della legge, e vincolante: entra a integrare la legge.
Fu il papa Giovanni XXIII a dare segnali di voler cambiare e ammodernare il nuovo codice, non adatto già ai tempi. Il nuovo codice fu promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 (con la Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae legis), con varie caratteristiche: armonizzazione del diritto sancito nel codice precedente ai vari concili, specialmente al Concilio Vaticano II, allontanamento dai codici secolari (contrario al codice del 1917 che vi si avvicinava notevolmente). Nell'ottobre 2008 Papa Benedetto XVI ha approvato la nuova legge sulle fonti del diritto per lo stato del Vaticano. La legge, entrata in vigore il 1º gennaio 2009, sostituisce quella del 7 giugno 1929, che fu emanata in seguito alla stipula dei patti lateranensi l'11 febbraio dello stesso anno.
La nuova legge riconosce che l'ordinamento canonico diventerà la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane e di altri Stati non verranno più recepite automaticamente, ma entreranno nell'ordinamento solo dopo una previa ed esplicita autorizzazione pontificia. Nel luglio 2013 con "motu proprio", quale sovrano assoluto, papa Francesco ha provveduto a modifiche della parte penale del diritto canonico, che si applica quasi esclusivamente all'interno dello Stato della Città del Vaticano.
Caratteristiche
Nonostante ovviamente sia radicato su una religione ben definita, il diritto canonico si discosta molto dalla shari'a islamica o dal diritto ebraico per essere molto vicino al diritto secolare degli stati,[senza fonte] ma allo stesso tempo non assume un'identità statale in quanto è destinato ad una massa di fedeli stanziata in tutto il mondo e non distribuita all'interno d'un territorio ben definito: parallelamente è distante dal concetto di stato anche perché il diritto canonico proviene ed è diretto ad un altro mondo e non quello terreno. Elemento caratterizzante della legge canonico è quindi la persona.[senza fonte] Si applica a pieno sia come diritto civile che penale all'interno dello Stato della Città del Vaticano.
In sostanza è costituito da quell’insieme di norme, provenienti direttamente dal papa (come sovrano assoluto), che:
- creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa;
- regolano tali rapporti;
- organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività;
- valutano e regolano i comportamenti dei fedeli.
Terminologia
La parola canonico deriva dal corrispettivo greco κανών, che significa semplicemente "regola", ed è stato usata in maniera inequivocabile nel Concilio di Nicea (325 d.C.) quando furono trattati i canones disciplinares, ma il suo uso ha cominciato a ricevere preferenze nette solo dall'VIII secolo. Tuttavia nel corso della storia della Chiesa si è parlato spesso anche di ius sacrum, ius decretalium, ius pontificium e ius ecclesiasticum. Dal Concilio Vaticano II il termine diritto canonico è stato spesso sostituito da quello di "diritto ecclesiale", che meglio risponde alle ragioni fondative della Chiesa.
Un'altra distinzione nasce dal fatto che la Chiesa si definisce un’unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, regolata correlativamente sia dal diritto divino sia dal diritto (meramente) ecclesiastico, ovvero dalle norme stabilite esclusivamente dalla competente autorità ecclesiastica. Si osservi che in questo caso con diritto ecclesiastico la Chiesa intende qualcosa di totalmente diverso da quanto indicato con lo stesso nome dagli stati, come spiegato in precedenza. Il diritto divino si divide in naturale e positivo: del primo fanno parte tutti i diritti umani intrinsechi alla natura umana stessa; del secondo tutte le regole manifestate nella Rivelazione divina, ricavabili dai testi sacri e dalla Tradizione apostolica.
Tratto da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vedi il "CODICE DI DIRITTO CANONICO" per intero su: http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM
Vedi anche:
99 Differenze tra l'Ortodossia e il Cattolicesimo Romano
Protestanti e cattolici: le differenze
